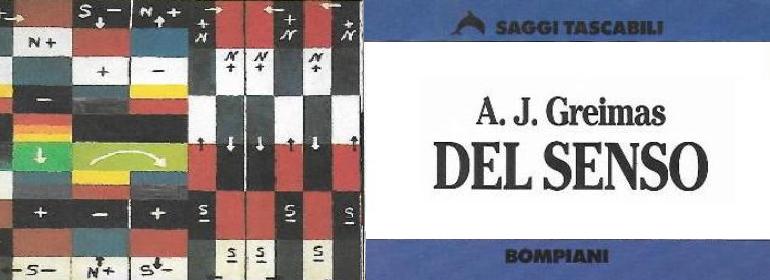LA VITA PENSATA
Me lo dicevi anche tu
la vita va vissuta
senza trovarci un senso.
Me lo dicevi anche tu
la vita va vissuta
e invece io la penso.
(La vita pensata – Brunori SAS)
Pensarsi, pensare l’altro, pensare la vita.
Pensare.
Pensare per capire, per comprendere.
Il rischio – come disse una volta, molti anni fa, Ruggero Chinaglia, in una conferenza – è quello della comprensione.
Pensare transitivamente è fuori dall’atto di nominazione.
È nella nomenclatura.
Le cose si nominano in quanto si qualificano.
Non per elencarle o per sistematizzarle.
Ne La Cifra, Armando Verdiglione scrive:
«L’atto di nominare è l’atto di nominazione. Il nominare è travolto e strutturato dalla nominazione. Di ciò prende atto Noè. La sua lingua proviene dallo scacco della lingua adamica. Non nomina le specie. Ne fornisce la rassegna sulla scia della nominazione. Dio sta ad indicare l’impossibilità di pensare le cose per potere nominarle».
L’impossibilità di pensare le cose per potere nominarle.
Non si pensa a qualcosa o a qualcuno.
Si pensa, certo.
Ma è una questione operazionale, non classificatoria, definitoria o descrittiva.
Pensare per comprendere, pensare per definire, pensare per chiarire, per chiudere la questione, è l’ipostasi.
Credere di poter pensare a qualcosa o a qualcuno è come credere di poter ritrovare un film in un fotogramma.
È nella totale negazione del divenire, del gerundio.
E pensare a qualcosa o a qualcuno è pensare all’idea. L’idea che abbiamo riguardo a qualcosa o a qualcuno.
Ma non c’è qualificazione in questo, perché è tutto nell’idealità.
Esattamente come pensare il tempo.
Contarlo. Quantificarlo. Teorizzarlo.
Il tempo non esiste fuori dal fare.
Anche contare il tempo in astratto è in una sorta di nomenclatura.
Il tempo “esiste” solo quando è qualificato dal fare.
Come diceva Shunryu Suzuki, se oggi alle cinque devo essere in un determinato posto per fare quella cosa… allora, le cinque saranno “fare quella cosa”.
Ma non esistono le cinque in astratto.
Ma dimmi un po’ che cosa stai cercando
io cerco la risposta,
mio padre l’aveva messa lì in ufficio,
ma qualcuno l’ha nascosta.
(La vita pensata – Brunori SAS)
Eppure pensiamo.
Pensiamo, rischiando la comprensione.
Ma cosa vuol dire rischiare la comprensione?
Perché mai la comprensione dovrebbe essere un rischio e non qualcosa cui tendere?
In fondo, noi parliamo, svisceriamo, argomentiamo…
A cosa serve tutto questo se non a comprendere, a capire?
Qui la questione è quella del fine (e della fine), oltre che della scelta.
I due aspetti mi paiono, in qualche modo, collegati.
Non ha un fine, quindi, tutta questa elaborazione e articolazione linguistica?
Dove ci conduce, se non a mettere in ordine le cose? Se non a sistemarle?
A cosa serve agli uccelli volare? A cosa serve ai pesci nuotare?
Forse gli uccelli volano e i pesci nuotano per spostarsi?
Per andare da A a B?
Se la questione è questa, allora, potrebbero anche scegliere di non farlo… o no?
E noi?
Potremmo scegliere di non parlare, di non dissertare, di non elaborare?
È, forse, una scelta la nostra?
La parola è una scelta?
Si può, dunque, scegliere di parlare o di non parlare, si può scegliere cosa dire, o come dirlo?
Possiamo scegliere le parole che usiamo?
Io sto scegliendo di scrivere queste cose?
E di scriverle in questo modo?
E se sto scegliendo, in base a quali criteri sto operando questa scelta?
E questi criteri, come si sono formati nel mio ragionamento?
Le parole che si trovano nella mia costellazione linguistica le ho forse scelte, le ho volute?
C’è stata, quindi, una sorta di selezione?
E ho scelto anche di scegliere?
Cosa sa un uccello del volo?
E quanto è forte la sua volontà di volare?
Ancora Suzuki ci dice:
«Finché continuate a pensare: “Io lo sto facendo” o “Io lo devo fare” oppure “Devo ottenere qualcosa di speciale”, in effetti non state facendo niente. Quando lasciate perdere, quando non desiderate più niente o quando non cercate di fare niente di speciale, allora fate qualcosa. Quando non c’è alcuna idea di conseguimento in ciò che fate, allora fate qualcosa.
Nello zazen ciò che fate non è in funzione di nient’altro. Può darsi che vi sembri di fare qualcosa di speciale, ma in effetti è solo l’espressione della vostra vera natura; è l’attività che appaga il vostro più profondo desiderio.
Ma finché pensate di praticare lo zazen in funzione di qualcos’altro, non si tratta di vera pratica».
Dunque… se l’uccello volasse semplicemente perché ha le ali?
E se il pesce nuotasse… semplicemente perché ha le pinne e si trova nell’acqua?
La parola, l’elaborazione e l’articolazione linguistica, non sono una scelta.
Parliamo perché abbiamo la parola (non nel senso di possesso, naturalmente).
O, più probabilmente, siamo parlati.
Siamo strutturati dalla parola.
“Esistere” è nella parola.
“Venire al mondo” è nella parola.
“Vivere” è nella parola.
Questa è la nominazione.
E non vi è scelta, né modo di sottrarvisi.
Anche quando siamo nella nomenclatura, la nominazione è già, comunque, in atto.
Che noi lo vogliamo o no.
Pensare, pensarsi, pensare l’altro, pensare la vita.
Sono, forse, quelle operazioni che in informatica si potrebbero chiamare operazioni “in background”?
Quelle operazioni, cioè, che la macchina deve compiere per mantenere attivo il sistema operativo, anche mentre non sta facendo nulla?
O è, semplicemente, una iperproduzione di senso?
E l’iperproduzione di senso non è anch’essa un’operazione “in background”?
E vi è un modo per arrestare questa iperproduzione?
Ho provato, talvolta, a rispondere a questa domanda… con scarsi risultati.
Forse, una strada potrebbe essere quella di “fare di più”?
Fare è certamente un ottimo modo per dissipare il pensiero transitivo (il cosiddetto “rimuginare”) e per instaurare il pensiero pragmatico.
Ma vi sono diverse obiezioni a questa possibile “soluzione”.
La prima è che il fare non è quantitativo.
Non si può “fare di più”.
Il fare non si può contare, non nel senso dell’accumulo, quantomeno.
La seconda è che, nel momento stesso in cui ci stiamo ponendo il problema… stiamo nuovamente iperproducendo senso.
Stiamo cercando una soluzione attraverso gli stessi meccanismi che innescano il problema che stiamo tentando di risolvere.
Quindi, paradossalmente, cercando una soluzione, stiamo alimentando il problema.
E questo ci conduce ad una terza obiezione, che sorge ancora una volta in forma di domanda.
Perché “dobbiamo” smettere di iperprodurre senso?
Crediamo ancora una volta di poter scegliere?
Tutto ciò, non è, forse, ancora una volta indotto da un’idea, da un senso predeterminato?
Dal credere di sapere (e a priori, per di più!) cosa va bene e cosa no?
Cosa è interessante e cosa no?
Dall’instaurarsi del senso come causa, anziché come effetto?
Per contrapporgli, così, un altro senso, sempre come causa, ma più corretto, più opportuno?
Per instaurare l’ascolto – senza moralismo, senza finalismo, senza volontarismo – dobbiamo prima di tutto partire dall’ascolto di noi stessi.
Ascoltare, senza zittire, senza orientare, senza censurare.
Senza sapere.
Non è facile, certo.
Ma, in fondo, si tratta di osare e di giocare un po’ di più… e, forse, di prendersi meno sul serio!
Ora… immagino che mi venga chiesto dal protagonista della canzone: ma allora… cosa devo fare?
Io non lo so.
Forse… proprio niente.
Ma non è un “niente” inteso come negazione.
Non è che si debba stare fermi e non fare niente (posto che stare fermo e non fare niente non sono la stessa cosa), è solo che la risposta non ha molta importanza.
Innanzitutto, perché non c’è una risposta.
In secondo luogo perché questa risposta presupporrebbe ancora di poter scegliere se fare e cosa fare.
E in terzo luogo, perché in questa domanda vi è ancora una volta un’idea di fine.
E il fare non è né transitivo, né finalistico, né addomesticabile o padroneggiabile.
Cosa devi fare?
Viaggia.
Che non è uno spostamento da A a B.
Quello, certamente, può essere un pretesto, un espediente… ma non è da intendersi realisticamente come la meta del viaggio.
Il viaggio è semplicemente mettersi in cammino.
Nella metafora, ovviamente.
Senza meta, senza fine, senza volontà.
Vincenzo Pisani
NOTE BIBLIOGRAFICHE.
- A. Verdiglione, L’intervento cifrematico, 1993, in SR,Il denaro, la moneta, i soldi, 24, 95, SPIRALI.
- A. Verdiglione, c. 21.12.1998.
- A. Verdiglione, 9-10.4.1994.
- A. Verdiglione, c. 6.3.2000.
- Shunryu Suzuki, Mente zen, mente di principiante, 1978, UBALDINI.