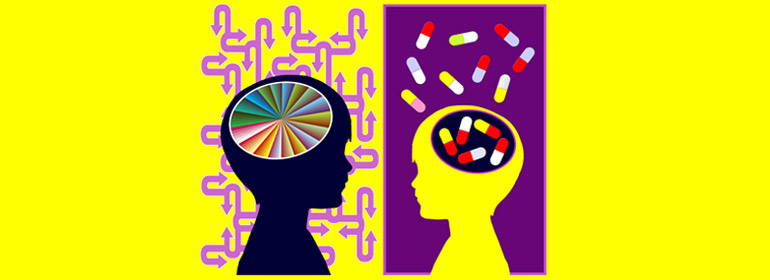IL CIELO, L’UOMO, LE GALASSIE, SENZA PIÙ PRINCIPIO DI IDENTITÀ
Siamo a Napoli, nella moschea di piazza Mercato, dove gli islamici sono guidati dall’imam Abdullah, che in realtà si chiama Massimo Cozzolino, è un ex appartenente alla Federazione giovanile comunista, ex frate francescano, con due lauree, una in filosofia e una in scienze politiche, e un master in peacekeeping; convertito a 36 anni, nel 1997, ha studiato l’arabo e il Corano a Londra.
Aldo Cazzullo, inviato qui dal “Corriere della sera”, scrive un articolo il 25 marzo 2016, in cui riporta l’intervista all’imam intorno al lavoro che sta facendo per segnalare sospetti di terrorismo: «Abbiamo lavorato molto – sostiene Abdullah Cozzolino –, abbiamo invitato qui sacerdoti, rabbini, poliziotti, scolaresche. Abbiamo detto a tutti i fratelli che quando incontrano un radicale, o anche solo uno che fa strani discorsi, devono segnalarlo. Non è delazione; è difesa della comunità. A Napoli e dintorni vivono 15 mila musulmani, e l’Isis purtroppo è un elemento di richiamo, inutile negarlo. Una tentazione. Ci sono giovani che non sanno chi sono e non sanno cosa fare, la pressione psicologica di Internet è fortissima, il fondamentalismo promette loro un’identità».
“Ci sono giovani che non sanno chi sono” e “il fondamentalismo promette loro un’identità”? Non sanno chi sono e non li ha mai sfiorati la lettura di Pirandello Uno, nessuno, centomila? Non sanno chi sono e qualcuno ha detto loro che possono saperlo, che devono saperlo, quindi loro, quando vogliono saperlo, si rivolgono a chi dice di saperlo, a chi sostiene di detenere tutta la verità, di non avere bisogno della ricerca e della scienza, perché sanno già tutto ciò che si deve sapere. Ma questo non vale solo per chi milita tra le fila dell’Isis, ma anche per chi si proclama seguace di Allah e considera il Corano come l’unico libro che occorra studiare, perché contiene già tutto. Per alcuni è il Corano, per altri è la Bibbia, con le debite differenze. Ma né gli uni né gli altri leggono veramente la Bibbia e il Corano, perché il fondamentalista non ha bisogno di leggere, interpretare, intendere nell’attuale, deve solo studiare ed eseguire, badando di evitare l’equivoco, la differenza e il malinteso, badando di evitare la poesia, l’invenzione, il gioco, l’arte, la scienza, la ricerca incessante, la parola libera.
Se analizziamo il termine identità, troviamo che è il più grande abbaglio della storia del pensiero. Chi o che cosa mai può mai avere un’identità? Noi viaggiamo nelle galassie infinite, nulla è mai fermo, ciascuna cosa è in viaggio, differente da sé, differente e varia rispetto a qualsiasi altra. Nulla è identico, simile o opposto a nulla. Addirittura, come diceva il sofista Gorgia, nulla è. Come arrivare a sapere chi si è o chi si vorrebbe essere, se nulla è? Se, come possiamo intendere dalla lettura del bel libro di Luigi Foschini, Scienza e linguaggio, l’essere è una parola come un’altra e non la sostanza di cui le cose, gli uomini, gli animali, le piante, i pianeti, le galassie sarebbero fatti? Un’intera branca della filosofia si è costituita per studiare l’essere e i suoi fondamenti: si chiama ontologia, dal greco ontos (participio presente del verbo einai, essere) e logos, discorso, dottrina. L’ontologia è lo studio del fondamento di quel che esiste, presumendo che qualcosa esista e che il fondamento di quel che esiste sia l’essere come sostanza immutabile. L’ontologia implica anche la ricerca del senso profondo di ogni essere reale, il senso dell’esistenza dell’uomo che pensa e che si pensa. Ogni domanda intorno al “soggetto”, all’“oggetto” e alla loro “relazione”, dunque intorno alla presunta relazione tra “io” e “mondo”, è una domanda ontologica.
Voi pensate che l’ontologia sia una faccenda relegata ai filosofi? E invece è la fonte da cui si riforniscono tutti gli spacci dei luoghi comuni più biechi, quelli che presumono di definire un io e un mondo e addirittura una relazione tra l’io e il mondo, come se fossero termini scientifici, riscontrabili attraverso chissà quali indagini con i più sofisticati strumenti (Foschini addirittura ci dirà che la cassetta degli attrezzi, anche per le indagini scientifiche, è costituita dal linguaggio). Chi non crede di essere alla ricerca della propria presunta identità, fino al punto da disperarsi perché non sa chi è o chi vorrebbe essere, fino al punto che, se ritiene di non essere abbastanza distinto dal fratello, dalla sorella, dalla madre, dal padre, può arrivare a compiere pazzie, pur di dimostrare la propria differenza come soggetto? Ma la differenza dell’uno non ha bisogno di essere dimostrata e il soggetto è anch’esso un postulato dell’ontologia. Nessuno è soggetto, anzi, l’atto, il fare, non richiede il soggetto, come notava già Nietzsche nel suo libro Genealogia della morale.
Ma quanti oggi si prendono la briga di leggere Nietzsche? Proviamo a seguirlo: “Il volgo separa il fulmine dal suo bagliore e ritiene quest’ultimo un fare, una produzione di un soggetto che viene chiamato fulmine. Ma tale sostrato non esiste: non esiste alcun essere al di sotto del fare, dell’agire, del divenire. Allo stesso modo la scienza sta sotto la seduzione della lingua e non si è sbarazzata di questi falsi infanti supposti, i soggetti”.
Come ribadisce anche Foschini, la lingua influenza la scienza. Ecco perché occorre prima di tutto una scienza della parola, che non dia per scontato ciò che si dice, che non lo consideri realistico, che non consideri la scienza come ricerca che miri alla conoscenza dell’essere come sostanza, come ciò che starebbe sotto le cose e le parole.
Ma perché a scuola non si studiano i sofisti, Protagora e Gorgia – che mettevano in discussione qualsiasi luogo comune volesse erigersi a sistema di pensiero –, anziché Platone e Aristotele, i principali artefici di quella dottrina che è stata chiamata ontologia e che imbriglia il pensiero nei binari dei sistemi filosofici, che costituiscono i fondamenti di tutto ciò che viene considerato il sapere o la scienza e che invece è il discorso scientifico come negazione della scienza libera e come trappola degli scienziati in quella Big Science ben descritta nel libro di Foschini?
Ho un’ipotesi di risposta a questa domanda: la paura del nulla, che era motivo di persecuzione degli stessi sofisti e lo è ancora oggi, appena qualcuno si azzarda a mettere in discussione le classificazioni, le categorie, gli ordini professionali e tutto ciò che si basa sul concetto di identità. Guai a chi mette in crisi quelli che sono stati presi come fondamenti del pensiero, della cultura, dell’arte, della scienza, della società, della politica, della vita di ognuno, ma che in realtà sono fondamenti che servono solo al tentativo di sistemare e sistematizzare ciò che è impossibile da mettere in un sistema, ciò rispetto a cui non c’è presa che tenga. Chi potrebbe racchiudere in un concetto il cielo, l’uomo, le galassie? Solo presumendo che se ne stiano fermi, immobili, allora potrebbero essere osservati, definiti, circoscritti nei loro presunti limiti.
Aristotele aveva paura dell’infinito, oltre che del nulla, così ha scritto interi volumi per classificare, definire, circoscrivere e per dimostrare che, se vogliamo appartenere alla comunità dei filosofi, ossia di coloro che amano la sapienza al punto da escludere chi non accetta i loro principi, dobbiamo rinunciare al cielo come apertura della parola e cercare la causa prima delle cose, il loro fondo, il fondamento, e dobbiamo farlo tenendo conto di principi e postulati che, secondo Aristotele, sono gli unici strumenti in grado di farci ragionare correttamente: uno di questi principi della logica aristotelica è proprio il principio di identità A=A.
A cosa serve questo principio? Finché si tratta di attribuire un significato convenzionale a un oggetto che in italiano si chiama “tavolo” e in inglese “table”, questo principio potrebbe anche essere valido, anche se del tutto inutile, perché a nessuno verrebbe in mente di discutere intorno all’identità di un tavolo. Anche se artisti come Matisse – che scriveva “Questa non è una pipa” sotto l’immagine di una pipa – si sono presi gioco persino della presunta identità degli oggetti comuni. Ma il vero problema sorge quando ci si sposta dai significanti che indicano oggetti per dir così tangibili a quelli che indicano qualcosa di astratto (chi potrebbe dire in modo inequivocabile che cosa siano l’amore, la bellezza, l’amicizia, l’odio, la cattiveria, l’invidia?). È lì, nei significanti che si riferiscono a astrazioni, che il principio di identità esplica la funzione per cui è sorto: quella di dare significato alle parole, di limitare i significanti a significati inequivocabili. Così, intendiamo che il principio di identità serve ai filosofi dell’ontologia soprattutto per nominare le cose, per denominarle e, in tal modo, dominarle. Perché? Sempre per paura del nulla e dell’infinito.
Non era così per il primo fisico della storia, uno dei massimi poeti di tutti i tempi. Leggiamo: “Se tutto lo spazio dell’intero universo fosse racchiuso da ogni lato entro limiti certi, e perciò definito, già la massa della materia, per il suo solito peso, sarebbe da ogni parte confluita nel fondo, nessuna cosa potrebbe generarsi sotto la volta del cielo, né esisterebbe affatto il cielo, né la luce del sole, poiché tutta la materia giacerebbero accumulata, addensatasi in basso ormai da tempo infinito. Ma senza alcun dubbio agli elementi primordiali dei corpi non è data alcuna sosta, poiché non esiste il fondo di tutto ove possano confluire e porre la loro sede. In assiduo moto sempre tutte le cose si traducono da ogni parte, e gli elementi della materia, precipitati dagli spazi infiniti, sono incalzati verso il basso. Inoltre è evidente al nostro sguardo che una cosa ne delimita un’altra; l’aria è confine dei colli, i monti dell’aria, la terra del mare, il mare a vicenda delimita tutte le terre; ma in verità non c’è nulla che all’esterno limiti l’universo”.
Non è Niels Bohr né Kurt Goedel a scrivere così, ma Lucrezio nel De rerum natura, nel I secolo a. C. Per Lucrezio non c’è il fondo delle cose, perché ciascuna cosa è in viaggio da tempo infinito, e non c’è un limite all’universo. Che interesse può avere l’essere delle cose, se esse sono in viaggio e differenti da sé, oltre che le une dalle altre?
Questa differenza da sé, non ammessa, produce i peggiori stermini, con l’aiuto delle ideologie, che si fondano sul principio d’identità, da cui discendono i principi di non contraddizione e del terzo escluso. Chi proclama l’identità di razza, di casta, di partito, di credo, ha bisogno di tenere lontana la differenza, crea comunità basate sui principi di elezione e di selezione. Ma quale scienza può sorgere sul principio di identità? Solo se la differenza da sé è ammessa ha effetti di sapere, di scienza (il termine scienza viene dal latino scio, che vuol dire “io so”). L’uno non è identico a sé, ma differente, diviso da sé. Questa la scienza, in una prima accezione. L’uno non si divide in due. Se l’uno si divide in due, allora, ognuno può pensarsi come angelo e demone, positivo e negativo, buono e cattivo, forte e debole, capace e incapace. Se l’uno si divide in due, al posto della scienza c’è la conoscenza, la gnosi, il cammino iniziatico che impone di arrivare al fondo del male per appropriarsi della scintilla del bene e portarla alla luce. Ma quanti sono gli scienziati non gnostici? E quanti sono gli pseudointellettuali, sedicenti scrittori, impregnati di ideologia illuministico romantica, che hanno prestato il fianco all’idea di sé come doppio? E quanti sono gli studiosi che hanno fatto della cosiddetta scissione dell’io o della cosiddetta crisi di identità un business? Quale scienza può coltivare chi si attesta sui principi della logica aristotelica?
Foschini ci fa notare che Kant fu l’ultimo dei filosofi naturali: dopo Kant, la filosofia e la scienza prendono strade differenti, e nel 1833 William Whewell coniò il termine scienziato come l’analogo di artista, ma dedicato alla scienza. Questo ci offre lo spunto per riflettere su un’altra accezione di scienza, quella che non si preoccupa del dominio sulle cose, sulla parola, sulla logica e sull’esperienza, ma dà notizia delle cose nella parola. Questa scienza è la presa della parola, come la definisce Armando Verdiglione: la parola presa nella sua logica e nella sua esperienza, la cifrematica. È la scienza che consente a Leonardo da Vinci di scrivere dipingendo e di dare così la vera notizia delle cose, anziché rendere omaggio ai trombetti dell’epoca che lo definivano “omo sanza lettere” perché ancora non conosceva il latino. Questa scienza che dà notizia dell’esperienza è attraversata, per dir così, dal tempo, ma non dal tempo cronologico, bensì dal tempo come taglio; temno in greco vuol dire taglio, come taglio è l’istante, di cui nessuno può dire nulla, eppure è innegabile, è ciò di cui Sant’Agostino diceva: “Se non mi chiedete che cos’è il tempo io lo so, ma se me lo chiedete non lo so”. Dicendosi, le cose si fanno, facendosi si scrivono, scrivendosi si dividono: sta qui la scienza, in questa divisione temporale, in questa impossibilità di occuparsene e di preoccuparsene. La cura è del tempo in questa accezione, pertanto chi dice che ha bisogno di cura fa appello al tempo. Purtroppo spesso immagina il tempo come la morte che con la sua falce incombe e annienta ogni cosa. Mentre il tempo è irrappresentabile, inimmaginabile. Vano il tentativo di chi presume di padroneggiare il tempo: chi può dire ciò che resta di ciò che si fa? Solo ciò che si scrive resta. Vano il tentativo di classificare, di dividere le cose in buone e cattive, mortali e immortali. La scienza non procede dal lavoro di un soggetto che “divide et impera”, che prende le cose per vere o false, che prende le cose, se la scienza è la presa stessa. Nessuno può prendere il posto del tempo e mettersi a dividere, ma ciascuno, con la scienza della parola, può dare notizia della divisione, della differenza e della variazione incessanti.
Foschini ha dedicato un capitolo alla logica particolare che è l’inconscio come idioma, come particolarità, come parola in atto, che mette in questione il conformismo e i luoghi comuni dell’epoca. Lo scienziato che procede dalla logica particolare può divenire caso di qualità, unicum, se non mira ad arruolarsi nelle fila di qualche comunità scientifica, ma procede dall’apertura, dal cielo della parola, e prosegue il suo viaggio nelle galassie infinite.